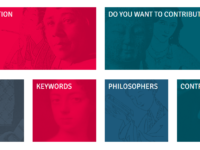Cominciamo con l’ammettere dal principio che in questa relazione mi occuperò solo marginalmente delle categorie di “inizio” e di “natalità” della Arendt. E questo non per eludere una parte della sua riflessione politica, bensì per due ragioni inerenti allo studio di questa stessa:
- durante la lettura di Vita Activa non ho potuto fare a meno di notare che pensare la creatività per la Arendt era un tutto uno con il pensare la distruttività. Di più, mi è parso che sin dal prologo le fosse impossibile scrivere di “inizio” se non a partire dalla “fine”. Da qui muove la mia prima “trasgressione” rispetto alla tradizione interpretativa femminista.
- E’ noto che la Arendt guardava con sospetto ogni -ismo, è altrettanto noto che non si dichiarò mai femminista. Eppure una certa tradizione femminista della differenza ha in ogni caso scelto di confrontarsi con il suo pensiero, privilegiando le categorie di natalità e di creatività, e la sua teorizzazione della soggettività come relazionale, la definizione di “condizione” umana piuttosto che di “natura”. La rilettura femminista della Arendt, però, si arresta di fronte ai suoi concetti di potere, di politica, di forza, di violenza, di distruttività in breve. Attenzione, si arresta nel senso che non condivide, non nel senso che “ignora”. Anzi, le femministe rivolgono alla Arendt molte accuse di “complicità” con il sistema eteronormativo, definiscono “maschilista” la sua visione del potere politico. Ed è così che mi sono scoperta curiosa, mi interessava capire cos’è per la Arendt il potere, se in qualche misura ha a che fare con la distruttività; cos’è per lei la violenza, ancora se le sue riflessioni possono esserci oggi di aiuto.
Vorrei dunque proporre a voi, come l’ho proposto a me, un piccolo esperimento. Accostare la lettura di Vita Activa (che è del 1958), uno dei suoi testi fondamentali, a quella di un piccolo saggio apparso nel 1969, dal semplice titolo “Sulla violenza”. In mezzo, tra questi due testi, nel 1963 esce la Banalità del Male, di cui non mi occuperò nello specifico, ma che mi serve qui per farvi notare la sconcertante attualità delle sue riflessioni politiche. Vi ricordate che la Banalità del Male nasce dal viaggio della Arendt a Gerusalemme come inviata del New Yorker per il processo Eichmann? ebbene Eichmann si era macchiato di ben 15 crimini durante il nazismo e per quelli veniva processato. Eichmann era per tutti il male, la distruttività. Ecco la Arendt quando descrive il male che lui incarna usa un aggettivo che lascia tutti basiti: il male è banale, il potere è distruttivo perché è banale, perché si fonda sulla banalità di tanti piccoli grigi burocrati, che non hanno nulla di speciale, di eroico, di mitico. Il male così come le appare nel XX sec è un fatto più “tecnico” che “mitico”. Si, a rendere efficace dal punto di vista politico il connubio male-potere è proprio l’esistenza di questi mille piccoli tecnici.
Queste sue riflessioni ci sono oggi di grande aiuto, oggi che la democrazia è solo un simulacro, per giunta malfunzionate, di quella che in effetti si presenta sempre più come una tecnocrazia. E non penso qui solo agli esempi di paesi più scottanti perchè più recenti, come la Grecia e la stessa Italia, ma a tutto il nuovo sistema di governance finanziaria internazionale, a tutte le sue comunità epistemiche e ai suoi comitati scientifici, che ci governano – banalmente- in modo tecnico e ademocratico: chi sono questi signori?cosa decidono?voi ricordate di averli votati?
Ecco la Arendt già denunciava la tecnocrazia ne “La banalità del male” ma anche in Vita Activa e nel saggio di cui vi parlerò nel dettaglio Sulla violenza.
Sono così giunta a ritenere che in Vita Activa vi è un’ intuizione fondamentale: tra potere nichilista, distruttivo, e tecnocrazia, si istituisce, nell’analisi arendtiana, un circolo vizioso. Nel saggio Sulla violenza diventa consapevolezza del fatto che, scienza tecnica e potere alimentandosi a vicenda, producono una serie di nefaste conseguenze, tra cui la scomparsa del dibattito pubblico, della politica come sfera del “ comune”, in breve della stessa democrazia.
Io trovo che sia assolutamente affascinante dal punto di vista storico il fatto che una donna non femminista negli anni 60 sia stata la prima a fare certe affermazioni oggi così attuali, come quelle a proposito dei rapporti tra pseudoscienza, tecnica e potere, e che, per ironia della storia della filosofia, siano oggi proprio delle filosofe e delle scienziate femministe a continuare il percorso aperto dalla Arendt: trovo che Donna Haraway, Sarah Franklin, tutte le femministe che oggi studiano i rapporti tra nuove tecnologie e bio-capitalismo stiano cercando di indagare la stessa area di problematizzazioni. Ma di questo semmai altrove, ora procediamo con ordine e cominciamo a dare uno sguardo ai testi sopraccitati per capire in primo luogo che spazio occupa la problematizzazione del rapporto potere-pseudoscienza nella sua produzione intellettuale.
In Vita Activa, opera nella quale la Arendt si propone di indagare “ciò che facciamo”, ovvero la condizione umana sotto 3 profili, attività lavorativa, operare e agire, questa problematizzazione ci si presenta sin dal prologo, dove si legge:
“(…) Non c’è ragione di dubitare del nostro potere attuale di distruggere tutta la vita organica sulla terra. La questione consiste solo nel vedere se vogliamo servirci delle nostre nuove conoscenze scientifiche e tecniche in questa direzione, ed è una questione che non può essere decisa coi mezzi della scienza; è una questione politica di prim’ordine, e perciò non può essere lasciata alla decisone degli scienziati di professione e neppure a quella dei politici di professione. (…) se la conoscenza si separasse irreparabilmente dal pensiero allora diventeremo esseri senza speranza, schiavi non tanto delle nostre macchine quanto della nostra competenza, creature prive di pensiero alla mercè di ogni dispositivo tecnicamente possibile, per quanto micidiale.”
Sono almeno tre gli aspetti che, a questo punto, occorre riprendere per un’adeguata genealogia arendtiana del fare politica tra scienza e violenza:
- Non è la scienza che incarna il male, a incarnare il male sono decisione politica e esiti che ne derivano. Se la politica decide di negare se stessa trasformandosi in tecnica, allora corriamo seri pericoli di vivere in epoche segnate dalla distruttività , piuttosto che dalla creatività.
- La Arendt nn ha paura del progresso, non è un antiprogressista. Quello che lei critica alla “pseudoscienza” non è l’abbandono di un mondo mitico, ancestrale, dalla natura incontaminata. Con la Arendt non c’è nessuna nostalgia di una primordiale armonia uomo-natura, per lei l’umanità è da sempre impegnata nella trasformazione del mondo. Quello che lei critica alla “pseudoscienza”, alla tecnica travestita da politica, è il processo da esse autorizzato che porta alla morte del pensiero: quando la conoscenza, nel senso di know-how, di competenza tecnica, si separa dalla capacità critica, allora perdiamo ogni speranza.
- Quando la Arendt parla dei nefasti effetti della pseudoscienza non ha in mente solo la bomba atomica. Certo quello del dopoguerra e della guerra fredda è un immaginario saturo di esplosioni, di ceneri, di radiazioni, di contaminazioni nucleari, di minacce aeree e missili puntati. Eppure è interessante notare che la Arendt ci fa altri esempi di pseudoscienza distruttiva, che sembrano evocare più l’immaginario attuale che quello dei suoi tempi. E anche qui, non posso non scrivere che l’ho trovata assolutamente geniale: per lei i ripetuti tentativi di creare la vita artificiale, di clonazione, gli esperimenti sugli animali, l’automazione a tutti i livelli dell’attività lavorativa, i primi lanci di satelliti in orbita, sono problematici quanto la moderna corsa agli armamenti resa possibile dalle nuove tecnologie militari.
Nel saggio Sulla violenza la Arendt va proprio al cuore di queste questioni e, descrivendo il XX sec come un secolo di guerre e rivoluzioni, sottolinea sin dall’incipit che, per comprendere come la violenza si sia acuita così tanto in così breve tempo, non bisogna ricorrere alla natura umana, a certe sue peculiarità innate, bensì al veloce sviluppo dei nuovi mezzi tecnologici. Leggiamo:
“Dato che la violenza ha sempre bisogno di strumenti (come faceva notare Engels molto tempo fa), la rivoluzione tecnologica, una rivoluzione nella fabbricazione degli strumenti, è stata particolarmente marcata in campo militare”.
Anche qui vorrei recuperare genealogicamente due elementi:
- La prima “immagine” di violenza che ci suggerisce la Arendt è la guerra.
- La guerra in quanto forma di violenza cerca i suoi strumenti nelle nuove tecnologie, all’epoca della Arendt trovandone una nella bomba atomica, poco più tardi nei batteri, oggi sappiamo che persino internet è nata come tecnologia militare. Per questo ci invita a diffidare dei comitati di esperti, dei circoli chiusi di scienziati e tecnici che si occupano solo di ciò che è “computerizzabile” senza preoccuparsi neppure di pensare (sto usando la sua terminologia)…lei dice “il guaio è che nn pensano affatto”.
Questa constatazione la porta ad un interrogativo che ci riguarda tutt@, considerando soprattutto che agiamo all’interno di università e che occorre sempre problematizzare i luoghi di produzione del sapere per capire in che modo alimentano i rapporti di potere. Pena non comprendere mai che il potere non è qualcosa che cala dall’alto ma qualcosa che autorizziamo nel momento in cui smettiamo di interrogarci e riproduciamo, banalmente, abitudini e comportamenti trasmessici. Questa del resto , è una delle lezioni arendtiane più importanti. E qui mi fermo per fare parlare lei, tornando al rapporto tra violenza\guerra e scienza\accademia:
“certamente niente è più importante per l’integrità delle università- le quali hanno tradito la fiducia del pubblico quando sono diventate dipendenti da progetti di ricerca sponsorizzati dal governo- di un divorzio rigorosamente rispettato dalla ricerca orientata a fini militare e da tutte le iniziative collegate”
Queste considerazioni la Arendt le inserisce in un quadro complessivo di critica alla modernità e ai suoi pilastri filosofico-politici-economici. Lei non crede semplicemente che per rompere il legame potere-guerra-violenza sia sufficiente reindirizzare la scienza, almeno fin tanto che lo stato nazione sia ritenuta la migliore forma di organizzazione politica, leggiamo ancora:
“né è probabile che appaia qualcosa che sostituisca la guerra finchè l’indipendenza nazionale, cioè la libertà da un dominio straniero, e la sovranità nazionale, cioè a pretesa a un potere incontrollato e illimitato negli affari esteri, continueranno ad essere ritenuti importanti”
Ciò non deve però indurci a pensare che non si dia potere senza violenza, che non siano possibili forme di governo non violente. Nella storia, è vero, spesso coincidono, eppure violenza e potere non sono la stessa cosa, come pure non sono la stessa cosa violenza e potenza. La violenza può sempre distruggere il potere, ma non potrà mai produrlo. Per produrre potenza individuale o potere politico ci vuole sempre la capacità umana di agire, di iniziare qualcosa di nuovo, che in nessun caso si dà quando si dà violenza. La violenza non è sostanza, ha natura strumentale, si appoggia sempre a dei mezzi, a degli strumenti per accrescere la sua efficacia, ci sono dei casi in cui la si può giustificare, ma mai legittimare. In questi passi la Arendt mi è parsa davvero molto lucida e poco ideologica. Quando la violenza è forma istituzionalizzata di potere, è tecnocrazia, assenza di democrazia, e come tale non può ritenersi fondamento legittimo di alcun potere politico. Ma quando la violenza è autodifesa , ad esempio, è giustificata, è ammissibile, è comprensibile. E questo non vale solo dal punto di vista individuale, ci sono casi e momenti storici in cui il ricorso alla violenza ha rappresentato l’unica strada per “autodifendersi” di molte soggettività marginali. La Arendt è puntuale a riguardo: la violenza dei movimenti degli studenti, o dei movimenti antirazzisti ha senso, è giustificata, solo quando persegue l’obiettivo immediato dell’autodifesa, per essere chiari quando si reagisce alle cariche immotivate della polizia; e quando vuole riconquistare dei diritti negati, ad es. quando si occupano le università contro le privatizzazioni: “ La violenza può rimanere razionale soltanto se persegue obiettivi a breve termine. la violenza non promuove cause, nè la storia nè la rivoluzione, nè il progresso nè la reazione; ma può servire a drammatizzare le ingiustizie e a sottoporle all’attenzione dell’opinione pubblica. (…) A volte la violenza è l’unico modo per essere sicuri che la moderazione sia ascoltata. Chiedere l’impossibile in modo da ottenere il possibile non è sempre controproducente.”
Quando, però, i movimenti ricorrono alla violenza per obiettivi molto lontani nel tempo, futuri, allora la Arendt smette di giustificarla. Usare la violenza in nome della costruzione del “sol dell’avvenire” è per lei ideologico e controproducente, si potrebbe anche aggiungere che sa di messianico e teleologico. Si corre il rischio di fare della violenza non solo il mezzo ma il fine, essendo l’iniziale obiettivo concretamente irraggiungibile, e poi si dimentica che la violenza non ha molto di “pubblico”, è più una forma di forza individuale moltiplicata grazie a degli strumenti, dunque non è in grado di costituire, senza la pluralità del mondo, per usare il linguaggio della Arendt, alcuna nuova forma di governo. La Arendt non è neppure una marxista, per cui non giustifica la violenza sul piano della sua creatività, eppure non si direbbe che sia una pacifista, una non violenta. Per lei la violenza esiste, e non servono a molto i giudizi morali del tipo “ la violenza è il male”, piuttosto le interessa negare alla violenza la possibilità di legittimare il potere politico tramite le nuove tecnologie, poiché come lei stessa scrive:
“La burocrazia è la forma di governo in cui ciascuno è privato della libertà politica, del potere di agire; perché il governo di nessuno è un non-governo, e dove tutti sono in egual misura senza potere abbiamo una tirannide senza tiranno.”
Allo stesso tempo la Arendt vuole assicurarsi che la violenza non sia espulsa dalla storia come “cattiva qualità dell’uomo”, causa di tutti i mali. Ancora leggiamo le sue parole a proposito:
“Nella vita privata come in quella pubblica ci sono situazioni in cui la semplice rapidità di un atto violento può essere l’unico rimedio appropriato. (…) In certe circostanze la violenza è l’unico modo di rimettere a posto la bilancia della giustizia. (…) In questo senso la rabbia e la violenza appartengono alle naturali emozioni umane, e curare l’uomo da esse vorrebbe dire disumanizzarlo.”
Bibliografia
▪ 1970 On Violence, tr. Aldo Chiaruttini, Sulla violenza, Mondadori, Milano 1971; tr. Savino D’Amico, Guanda, Parma, 1996 ISBN 8877468874 ISBN 8882463885 ISBN 9788882463885
▪1972 Crises of the Republic [4 saggi] ▪
Lying in Politics, tr. Savino D’Amico, Politica e menzogna, con un saggio di Paolo Flores d’Arcais, SugarCo, Milano, 1985,
▪ Civil Disobedience, tr. Teresa Serra, La disobbedienza civile e altri saggi, Giuffrè, Milano,
▪ 1978 The Life of the Mind, tr.Giorgio Zanetti, La vita della mente, a cura di Alessandro Dal Lago, Il Mulino, Bologna, 1987
▪ 1981 Il futuro alle spalle, tr. Valeria Bazzicalupo e Silvano Muscas, antologia di articoli a cura di Lea Ritter Santini, Il Mulino, Bologna 1981 (n.ed. 1995),
▪ 1951 The Origins of Totalitarianism (n.ed. 1958, 1966), tr. Amerigo Guadagnin, Le origini del totalitarismo, introduzione di Alberto Martinelli, Edizioni di Comunità, Milano, 1967 Bompiani, Milano, 1977; con un saggio di Simona Forti, Einaudi, Torino, 2004 I
▪ 1958 The Human Condition, tr. Sergio Finzi, Vita activa, introduzione di Alessandro Dal Lago, Bompiani, Milano, 1964