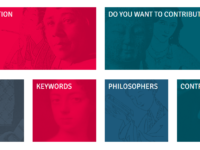Riallacciare di nuovo il legame tra pensiero, linguaggio e vita, riapprendere, re-agire; questo il fine della riflessione arendtiana che Hannah Arendt. Un ritratto controcorrente raccoglie. La serie di saggi di cui si compone il volume di Marie Louise Knott fa propria l’esigenza arendtiana di apprendere ad esperire di nuovo il mondo, aldilà del silenzio del pensiero davanti al quale pone l’esperienza buia del totalitarismo, e rilegge alla luce del presente le pratiche che in Arendt risvegliano la riflessione dalla paralisi, per aprire lo sguardo sul mondo, lasciandosi colpire e sorprendere, anche nello sgomento, dalla vita e dalla realtà. Ci si concentra dunque su quelle esperienze che è fondamentale riapprendere per comprendere il mondo, sui modi di re-agire al buio di esperienza e di pensiero a cui il declino e la svalutazione di ogni discorso radicato sulle esistenze è condannato nei momenti di crisi della politicità dell’esistenza. Tutto questo in un’ottica nuova, insolita, mobile e fluida come il pensiero di Arendt e la stessa contingenza dell’esistenza su cui questo si fonda.
Innanzi tutto ridere. Ridere davanti al vuoto di pensiero, al non agire, all’alienazione e alla messa in questione della capacità umana di agire e giudicare di esistenze come quella di Eichman. Ridere davanti alla perversione dell’agire come funzionare. Il riso mette in parola quell’orrore, quel vuoto dell’alienazione di cui Eichman ci testimonia, senza cedere al silenzio e al crollo a cui questo costringerebbe il pensiero. L’ironia è il mezzo che Arendt individua come messa a distanza del vissuto, riflettendo su di esso e proteggendo al contempo il pensiero dal panico che impedisce il giudizio. Ridere è dunque momento di libertà e sovranità sull’ineluttabilità dell’esistente, sui paradossi del vivere. È forza liberatrice, capace di oltrepassare la realtà, che mette in movimento le differenze divenendo occasione di legame. Il riso getta un ponte, sospende il pathos, custodendo l’esperienza della diversità, preservando un dialogo con il reale e con l’alterità.
Tale dialogo può essere mantenuto e custodito anche tramite la pratica del tradurre. Non solo custodito, lo scambio può ricevere da questa esperienza nuovi impulsi, nuova forza. Come esperito dalla stessa autrice nella sua coraggiosa esperienza in America, tradurre non è il semplice gesto di trasferire in una lingua altra e sconosciuta il proprio mondo, dal momento che ad una graduale penetrazione nella lingua corrisponde una graduale penetrazione nella cultura e nella politica di un nuovo paese. Non si tratta dunque di assimilarsi, di integrarsi nel nuovo contesto scomparendo, perdendo la naturalezza e la spontaneità dell’espressione. La lingua, infatti, è luogo di articolazione del pensiero, modo in cui il mondo ci viene dato. Il gesto di oltrepassare, poco a poco, attraverso la pratica del tradurre è gesto liberatorio di un pensiero che non può concepirsi aldilà della lingua ma può fuoriuscire dalla propria cultura, liberando così qualcosa di nuovo. Da pratica necessaria, il limite del tradurre diviene invece un approccio politico, un portare all’esterno la propria lingua, cultura, dimensione di esperienza; un tra-durre.
Ricomprendere la centralità e il valore politico del perdono è la terza esperienza che la pratica di pensiero arendtiano pone come atto di riappropriazione del reale, della capacità di lasciarsi sconvolgere ancora dall’esistente. L’esperienza del perdono è pilastro della teoria politica arendtiana e si pone come criterio etico inter-soggettivo, attraverso una decisa riattualizzazione del concetto cristiano. Perdono e promessa sono infatti per Arendt azioni che suggellano e garantiscono la stessa libertà della politica. Il gesto del perdono è atto stesso di libertà, di esposizione all’altro e al fallimento: chi chiede perdono, infatti, si espone alla libertà di non esser perdonato. Attraverso questa centralità della libertà propria e altrui, il perdono acquisisce dimensione propriamente politica e si pone come esperienza concreta del riconoscimento dell’umano nell’altro, della sua capacità di cambiamento, azione e parola. Il perdono dunque è un riconoscimento e un patto tra esseri liberi, dalle conseguenze imprevedibili. Esso non prescrive l’oblio («le azioni restano, non vengono dimenticate, ma non devono frapporsi tra gli individui», p. 85) ma sancisce un legame politico tra due esseri liberi di agire nel mondo.
Infine, drammatizzare. La capacità di agire nel mondo e nella politica corrisponde alle potenzialità di cambiamento di attori sulla scena. Ogni attore politico, con il suo semplice comparire, può cambiare il mondo e il reale. Per farlo, però, l’essere umano ha bisogno di una scena, di colleghi, di spettatori. L’immagine del teatro come metafora dell’agire politico distanzia Arendt dall’accezione heideggeriana di essere-nel-mondo: gli esseri umani, spiega Arendt, non sono infatti gettati nel mondo, bensì sulla terra, e nel mondo si inseriscono tramite l’azione e la parola, che hanno bisogno di pluralità e apparire per essere. Come nel teatro antico, in cui la maschera si pone come modo di apparizione autentico sulla scena, chi agisce politicamente appare sulla scena pubblica attraverso l’azione del personare. La maschera della tragedia antica, infatti, si pone come metafora della differenza che intercorre tra le due dimensioni essenziali della politica, il pensare (azione infinita di dialogo con se stessi) e il parlare (legato all’istantaneità, all’unicità, al cambiamento del mondo). La maschera si pone quindi come metafora del pensiero personificato, che agisce rivelando il vero io dell’umano, che altrimenti la natura nasconderebbe nell’indifferenziato. Agire sulla scena pubblica è dunque gesto di distacco e contatto con il reale e con se stessi, attraverso un agire comune.
Imparare da Arendt a rileggere il mondo, a riappropriarsi della propria posizione in esso. Questa è l’idea del testo di Marie Louise Knott, che riprende da Arendt quel saper “saltare” oltre le contraddizioni del presente, che ammutoliscono, che bloccano il pensiero, tornando alle pratiche, al mondo, per poterlo guardare aldilà del buio del terrore. I testi di Arendt nascono propria da questa esigenza, dal riappropriarsi di luoghi e pratiche per pensare e vivere il mondo, manifestando la propria singolarità, aldilà della svalutazione di ogni discorso, di ogni riflessione a cui porta il contesto totalitario (e non solo, diremo noi). Abbracciando e facendo propria tale prospettiva, il testo di Marie Louise Knott trova nelle pratiche individuate da Arendt come luogo per ridar vita al pensiero, non solo un’occasione per interagire con l’autrice, ma strumenti validi per il nostro presente. Un’operazione del genere è estremamente lodevole per la sincerità con cui si lega al pensiero stesso di Hannah Arendt, liberandone la riflessione dai lacci degli studi meramente accademici (che tanto contraddicono le intenzioni della stessa riflessione arendtiana), riconsegnandolo all’agire e al mondo, ma non solo. Tale gesto si rivela infatti di estrema profondità politica in un contesto globale quale quello attuale, in cui l’ideologia neoliberista declinata nel contesto della crisi, del precariato come nuova antropologia umana, porta di nuovo alla paralisi del pensiero, al buio del giudizio. I testi di Arendt mostrano il potere immenso di non esaurirsi nella lettura, né nel contesto loro contemporaneo. Essi sanno arricchirsi ad ogni lettura, divenendo luogo di scambio e relazione politica tra chi legge e chi ha scritto, divenendo così possibile luogo di riflessione sul contemporaneo. E, in questi tempi, riacquisire la capacità di lasciarsi scuotere e turbare dalla realtà, acquista estremo significato politico, ponendosi come strategia di libertà.